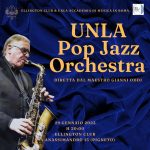Educazione permanente
Il dibattito in corso nel nostro paese tende a concretizzare, in linea con quanto sta avvenendo nel resto d’ Europa, l’ idea di una società “ in formazione”, che offre a ciascun cittadino, in ogni momento e fase della vita, l’opportunità di crescere, migliorare il suo status sociale, di prevenire situazioni di disagio e di emarginazione.
Per rispondere alla costitutiva instabilità dei saperi e alla tendenziale obsolescenza delle competenze acquisite nelle consuete occasioni di formazione, la proposta europea punta a sviluppare nei singoli la capacità di “apprendere ad apprendere”, ovvero di acquisire modelli, motivazioni, e capacità di guidare, anche autonomamente, un processo ininterrotto di aggiornamento e sviluppo delle proprie conoscenze, tale da favorire la possibilità di autonomo controllo e progettazione di intervento sul contesto di vita e di lavoro individuale. Emerge in maniera pervasiva l’esigenza che le persone, nel corso di tutta la vita, devono acquisire competenze non date una volta per tutte, ma implementabili (v. Conferenza di Amburgo del luglio 1997). Importanti traguardi per istruzione, formazione, ricerca e lavoro, sono stati fissati dal Consiglio d’Europa, a Lisbona, nel marzo 2000, e ruotano intorno al concetto di sviluppo, sviluppo soprattutto della persona e dei suoi diritti al riconoscimento dell’istruzione e della formazione comunque dovunque acquisti (wide life learning), perché la formazione della persona avviene in diversi contesti, formali, non formali, informali. Importanza fondamentale assumono, quindi, i processi di apprendimento per competenze; il Consiglio d’ Europa dell’8 Dicembre 2006 inquadra le competenze chiave, per continuare ad apprendere per tutto il corso della vita, come una combinazione di conoscenze, abilità, e atteggiamenti appropriati al contesto e finalizzate alla realizzazione personale, all’esercizio consapevole della cittadinanza, alla coesione sociale e all’occupabilità.
Da qui la necessità di esprimere nei contesti lavorativi, ma anche esistenziali, nuove conoscenze e competenze all’ interno di uno sfondo connotato da cambiamenti veloci e, nello stesso tempo, dall’ incertezza delle loro evoluzioni.
Il nostro Parlamento nel Luglio 2007 ha approvatole Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio D’ Europa con il Quadro di Riferimento relativo alla strategia diLisbona 2010 contenuto nel Trattato di Lisbona in merito all’ istruzione-formazione permanente da prima della scuola a dopo la pensione.
Il Documento Europeo indica come”attitudine primaria” nel processo di formazione permanente la competenza di imparare ad imparare, finalità che può essere raggiunta solo con l’assunzione volontaria e consapevole di un atteggiamento mentale e pratico nei confronti dell’odierna realtà europea.
Sappiamo che l’acquisizione di nuovi meccanismi mentali, ossia di nuovi paradigmi con i quali guardare e interpretare in modo diverso gli stessi dati e informazioni prevedono processi evolutivi che hanno tempi di realizzazione non certamente rapidi, riteniamo, però, che migliorare la conoscenza delle dinamiche della comunicazione costituisce premessa indispensabile per una “positiva interazione” con la realtà: la mancanza di questa competenza può essere considerata una delle forme più subdole di analfabetismo.
E’ necessario imparare a decodificare e padroneggiare la pluralità dei “testi”dai quali siamo investiti in ogni momento e in ogni situazione della nostra vita , è necessario educare alla consapevolezza delle relazioni che sussistono tra i diversi linguaggi e del carattere multiforme del tessuto che questi vanno a costituire per la comunicazione degli esseri umani. I linguaggi, infatti, verbali, nonverbali, multimediali sono generativi del sapere stesso, sono trasversali ai saperi, sono pervasivi.
In linea con quanto fin qui detto, la nostra proposta educativa si muoverà nell’ottica dell’ Asse culturale Linguaggi del Regolamento per l’innalzamento dell’ obbligo di istruzione e delle Raccomandazioni che accompagnano le competenze chiave di cittadinanza per l’apprendimento permanente.
Nel breve e medio termine, il nostro obiettivo, certamente ambizioso, ma necessario , è mettere la persona-studente in grado di “leggere” un grafico cosi’ come un’opera d’arte, un messaggio pubblicitario cosi’ come un articolo di giornale,un testo musicale cosi’ come un testo iconico, un messaggio del corpo cosi’ come una e.mail o un sms, una rappresentazione cinematografica cosi’ come la sequenza delle notizie dl telegiornale. Siamo consapevoli che l’ esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dell’inclusione e dell’integrazione non è una conquista immediata, ma “big changes by little changes”; importante è aprire una discussione sugli stili cognitivi che finora hanno orientato i processi di apprendimento, al fine di individuare i percorsi e i modelli mentali che consentono di approssimarsi alla soluzione dei problemi e all’ acquisizione delle conoscenze, spostando il proprio baricentro non sul passato, sulla certezza dei cicli e dei relativi risultati, ma in avanti, su un futuro tutto da costruire, da generare sulla base di un progetto.
Una particolare attenzione merita la riflessione sulle conseguenze vaste e penetranti dovute ai media che ci circondano e che modificano in profondità le nostre abitudini, ma soprattutto le operazioni della nostra mente .
“Life is now”, “Think different”, sollecitano gli spot pubblicitari rispettivamente della Vodafone e della Apple, con virale pervasività; i loro ideatori conoscono perfettamente le modalità di attivazione di quel processo di “esattamento” per il quale “funzioni e bisogni prima inesistenti vengono alla luce e diventano perfino urgenti appena si rende disponibile un mezzo tecnico capace di soddisfarli”. Siamo diventati consumatori compulsivi di tecnologia, interlocutori distratti, comunicatori inquieti e invadenti; l’ uso indiscriminato e l’ “ubiquità” delle “protesi tecnologiche” ha già avuto effetti vistosi sul modo di relazionarci agli altri all’interno di spazi pubblici, ma sicuramente sono i nostri sistemi e processi culturali ad essere stati messi in discussione, c’è il mutamento radicale di una società e dei suoi fondamenti: la trasformazione tecnica e la rivoluzione digitale pone un nuovo paradigma della conoscenza che privilegia il “guardare” al “leggere”, l’homo sapiens è sul punto di essere soppiantato dall’ homo videns. La svolta antropologica-evolutiva in atto ha messo in discussione anche la scuola, in crisi di legittimazione come “agenzia”di formazione e di diffusione del sapere; c’è il rifiuto dell’apprendimento graduale e progressivo, ritenuto troppo faticoso e lento,rispetto alla iper-velocità della rete, la cultura della scuola educa all’analiticità, al controllo linguistico, allo spirito critico, alla necessità di tradurre in parole il proprio mondo interiore e la propria esperienza; per i giovani le esperienze è meglio averle, rievocarle, piuttosto che raccontarle analiticamente e tradurle in strutture discorsive.
Per effetto di questo cambiamento stiamo passando da una intelligenza sequenziale (sulla quale poggia quasi tutto il patrimonio dell’uomo occidentale) ad una intelligenza simultanea, capace di trattare nello stesso tempo più informazioni, senza essere in grado di stabilire una gerarchia e quindi un ordine.
Qualcuno afferma che la rete ha contribuito e contribuisce a rimodellare spazi di democrazia, non solo virtuale; certo, come sappiamo, il web e l’hardware che ne garantisce l’accesso hanno permesso, tra l’altro, nuove forme di partecipazione diretta al dibattito politico: hanno contribuito all’esplosione della “primavera araba” al successo della mobilitazione di massa come quella degli “indignati”, ma sappiamo anche che il controllo sulla “mediasfera” è ferreo, che forme di intrattenimento online sono studiate apposta per sviare l’attenzione dei giovani dall’impegno.
Sono d’accordo con R. Simone quando dice che il “movimentismo reticolare” mostra fragilità evidenti quando dalla protesta occorre passare alla proposta, dal momento che i messaggi sono spesso eterodiretti, rifuggono la mediazione, che costituisce uno degli elementi fondamentali della democrazia.
Tutto questo non significa guardare con nostalgia al passato, né tanto meno proporre una visione apocalittica, ma riteniamo che compito di ogni intervento educativo-formativo, in qualsiasi contesto avvenga, sia quello di fornire metodi di ricerca e capacità di giudizio; non ci si può opporre alle innovazioni epocali, ma si può evitare di accettarle senza sapere che cosa si sta facendo.
Bene l’introduzione della cultura digitale nella scuola, ma nella consapevolezza della sua potenzialità ambivalente, che richiede una attenta gestione e un approfondito spazio di riflessione.
Vorrei concludere affermando che un computer non può sostituire un buon insegnante e che 50′ di lezione non possono essere “liofilizzati” in 15′ multimediali e che per avere successo e capacità di realizzare il proprio progetto di vita non sono sufficienti le tanto decantate 3 I (impresa, internet, inglese) perchè per pensare, per ragionare, ma anche solo per parlare occorrono tutte le lettere dell’alfabeto.